I terrazzi
I terrazzamenti (i ronchi) sono certamente la caratteristica principale del paesaggio del Parco
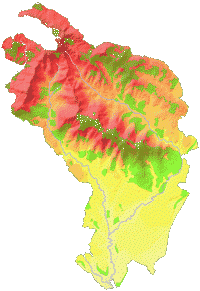
Il versante meridionale della collina di Montevecchia,
che si offre allo sguardo di chi proviene da sud, è la
testimonianza evidente di una tradizione agricola ancora
viva ed è il segno più evidente dell'azione dell'uomo
sull' aspetto del paesaggio.
Le sistemazioni dei versanti delle colline fanno infatti parte di
quelle trasformazioni che, a partire dall'epoca romana, cambiarono
completamente la morfologia del territorio locale, avviando lo
sfruttamento delle risorse e trasformando il passaggio da ambiente
naturale a territorio rurale.
Sui terrazzi che modellano i versanti soleggiati delle colline
(i versanti settentrionali e freddi erano solitamente lasciati a bosco)
è da sempre coltivata la vite da cui si ottiene il tipico vino di Montevecchia.
Ai filari di vite si alternavano poi abitualmente rosmarino, ortaggi e
piante da frutto per sfruttare al massimo lo scarso spazio disponibile
sulle piane e per fornire una vasta gamma di prodotti che garantissero
rese e produzioni diversificate.
A volte i ronchi venivano identificati nella toponomastica locale anche
attraverso l'indicazione della coltura che su di essi trovava spazio
(Runchet de la pera, Runchet di por).
Prima della comparsa del mais, sui terrazzi erano poi presenti cereali
quali miglio e segale (coltivati in piccoli appezzamenti), a cui seguì il frumento.
A partire dagli anni 50 del secolo scorso
la perdita d'importanza delle pratiche agricole ha portato ad un progressivo
abbandono delle zone collinari e dei terrazzi (a causa delle difficoltà di
accesso e coltivazione di tali ambienti), prima lasciati a prato o pascolo,
poi definitivamente abbandonati.
Dagli anni '80 del secolo scorso però si assiste ad un rinnovato interesse per la viticoltura e
per la coltivazione delle erbe aromatiche, e i terrazzi soleggiati tornano ad
ospitare le colture tradizionali del territorio, affiancando alle attività agricole
alcune zone di importante valore naturalistico ( i prati magri dei versanti
della Valle del Curone).
Nelle tre immagini a fianco, dall'alto: il mutamento di paesaggio avvenuto nell'area dei prati magri, dal periodo di transizione, in cui le superfici erano mantenute a prato stabile, alla ripresa della viticoltura negli anni novanta.
La superficie del Parco occupata dai ronchi

una antica muratura
è di circa 515 ettari (le aree in verde nella cartina riportata in alto
rappresentano le zone terrazzate del Parco) ed i terrazzi sono sostenuti,
nelle zone a maggior pendenza dei versanti, da centinaia di chilometri di
murature (alcune delle quali antichissime e difficilmente databili) in pietra
molera (cavata nella zona) disposta a secco.
Oltre all'importante funzione di sostegno e difesa idrogeologica
esercitata dagli estesissimi sistemi di murature a secco, oggi si
riscopre anche il "valore ecologico" di tali strutture.
I muretti diventano quindi luogo favorevole per la crescita e lo sviluppo
di specie vegetali ed animali legate ai veri e propri ecosistemi che
questi particolari ambienti costituiscono.
Nell'ambito del Progetto il Parco ha avviato il ripristino di alcune murature
site nei dintorni della sedi di C.na Butto, promuovendo
un corso sulle tecniche di costruzione e manutenzione.
Loc. Butto, 1 - 23874 Montevecchia (LC) — C.F. 94003030130, P.I. 02236220139
Tel. 039.9930384, PEC certificata@pec.parcocurone.it
Albo pretorio — Contatti — Privacy






